Biblioteca
| Parole chiave | |||
|---|---|---|---|
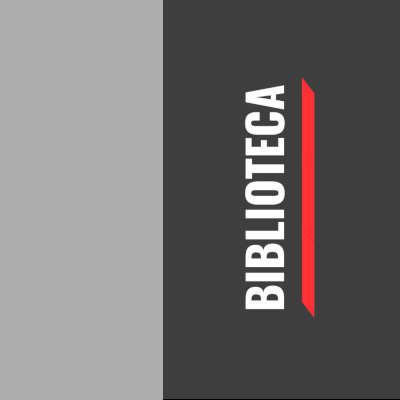
|
Il video a 360° nella didattica universitaria |
tecnologia immersiva, video 360°, didattica |
|
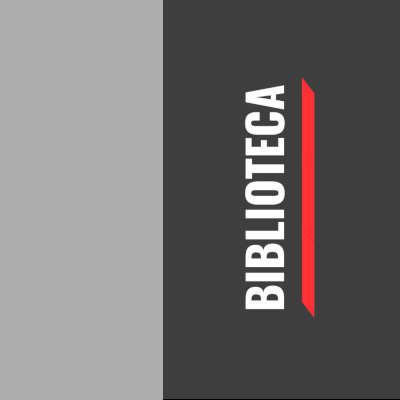
|
Il Tirocinio Diretto Digitale Integrato (TDDI) |
L’apprendistato digitale diretto integrato rappresenta una nuova e cruciale modalità di apprendistato sperimentale con la funzione primaria di garantire a tutti la possibilità di vivere tutta questa esperienza pre-professionale attraverso modalità virtuali e ampliare e arricchire opportunità formative per futuri insegnanti pre-primari e insegnanti primari. Il progetto sperimentale nasce dalla necessità di rispondere alla necessità di garantire la praticabilità dei corsi di formazione professionale in un momento in cui, a causa della pandemia, non era possibile ospitare tutti gli studenti nelle scuole. È stato progettato con l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e derivato dal corso di laurea costante impegno nei confronti della USR Toscana per garantire agli studenti; diritto allo studio e alla valorizzazione delle scuole; disponibilità ad accogliere tirocinanti. |
società, edicazione, insegnamento, cultura digitale |
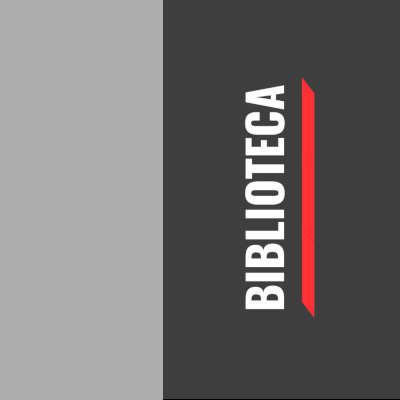
|
Formazione, lavoro e tecnologia |
La tecnologia ha cambiato radicalmente il modo in cui impariamo e lavoriamo, e questo fatto apre nuove strade per esplorare e indagare. Alcune domande che ci guidano in questa ricerca sono: qual è il rapporto tra formazione, nuove tecnologie e lavoro? Qual è il ruolo delle organizzazioni nel far imparare ai lavoratori e nel sostenerle per affrontare le trasformazioni? Partendo da un’analisi teorica ed epistemologica del rapporto tra formazione, tecnologia e lavoro, il libro è incentrato sulla descrizione del ruolo della formazione di fronte ai concorsi attualmente e all’esame di alcuni nuovi strumenti metodologici per sviluppare l’apprendimento e le competenze, come e-service-learning e design thinking. |
learning, apprendimento, tecnologia |
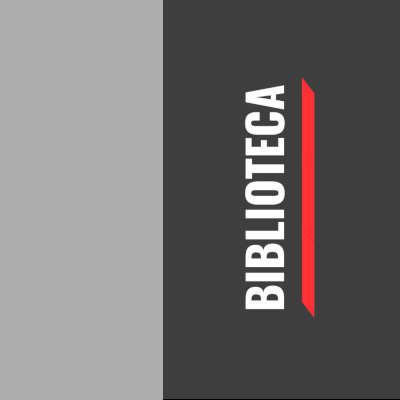
|
Fare Open Access |
Lo spunto definitivo e concreto per realizzare questo libro nasce però più precisamente da un incontro formativo tenutosi presso il CRO di Aviano nel settembre del 2016 e del quale questo prodotto editoriale rappresenta in un certo senso gli atti ufficiali. Dico “in un certo senso” perché in realtà l’intento era quello di andare un po’ oltre la semplice raccolta di relazioni tenute a un convegno, arrivando a ti- rar fuori uno strumento di informazione e divulgazione che potesse risultare utile anche in ottica più ampia. Una guida che tenga in considerazione nella giusta proporzione sia il background teorico scientifico che fa da sfondo alla diffusione della conoscenza scientifica in modalità aperta, sia indicazioni pratiche e operative capaci di guidare gli operatori del settore a fare Open Access e a farlo correttamente ed efficacemente. |
copyleft, IT, dati aperti, open data |
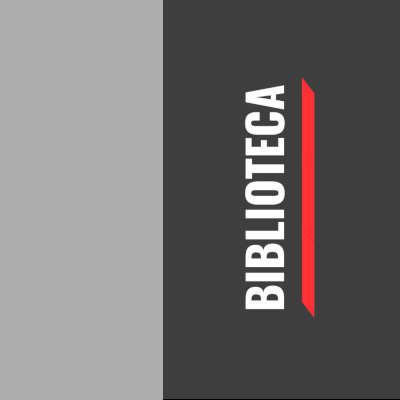
|
Fabbrica 4.0: I processi innovativi nel Multiverso fisico-digitale |
Gli obiettivi di questo contributo sono molteplici. Il primo è quello di effettuare una ricognizione sistematica degli studi concernenti l’insieme dei processi innovativi, sintetizzati in ambito internazionale con espressioni sostanzialmente equivalenti: Industrie 4.0 (Germania), Industrial Internet e Advanced Manufacturing (Usa), L’Usine du Futur (Francia), High Value Manufacturing (Inghilterra), Fabbrica Intelligente (Italia). |
digitalizzazione, innovazione, multiverso |
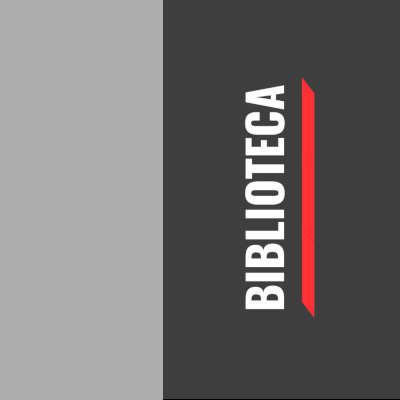
|
ES-LCA e patrimonio naturale |
La protezione dell’ambiente, la tutela delle risorse ecologiche e naturali, la valorizzazione sostenibile degli spazi urbani e rurali rappresentano per le società del terzo millennio degli incontestabili paradigmi etici e delle ineludibili realtà con le quali confrontarsi: in tal senso, è riconosciuta l’esigenza, sempre più pressante, da un lato di sottrarre parti del territorio al degrado e a pratiche non sostenibili, dall’altro di superare una concezione che mira a preservare la natura sottraendola all’influenza antropica, per muovere verso una nuova frontiera della conservazione dei “paesaggi storici” realizzati attraverso le modifiche operate sul territorio dall’Uomo nel corso dei millenni. Alla tutela ambientale – già di per sé meritoria – si sono così affiancati obiettivi più ampi, connessi alla fruizione dei contesti territoriali, in un’ottica di conservazione attiva, e si sono modificate le strategie di intervento in funzione della valorizzazione di risorse e contesti, nonché dello sviluppo delle specificità del territorio stesso, valorizzando e potenziando le risorse materiali e immateriali locali attraverso programmi di intervento coordinati e strutturati. |
open data, ecologia, sviluppo cittadino, politica cittadina, sostenibilità urbana |
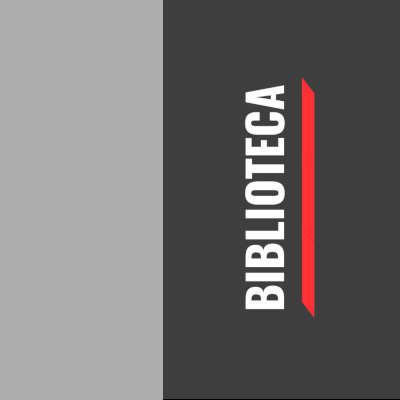
|
Ebook e dati della lettura |
dalla Premessa: Raccogliamo gli atti di due convegni svoltisi al Centro Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli studi di Salerno e organizzati in collaborazione con la sezione Campania dell’Associazione Italiana Biblioteche. Il primo (5 dicembre 2017), occasionato dal ventennale dell’apertura della Biblioteca Caianiello, era incentrato sul tema Ebook e biblioteche accademiche; il secondo (17 aprile 2018) si tenne nell’ambito degli eventi organizzati per il Salone del Libro di Napoli e trattò di Editoria e lettura nel Mezzogiorno. I contributi sono stati ordinati per tipologia: una prima parte contiene le relazioni, la seconda le interviste. Completa il volume un’appendice bibliografica. Hanno collaborato all’elaborazione delle interviste Remo Rivelli e Ida Stringile. |
ebook, dati, Salerno, università di Salerno |
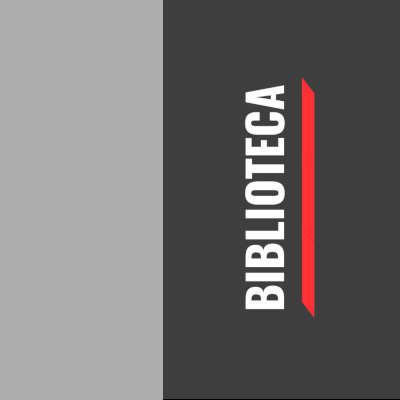
|
Diritto comparato della privacy e della protezione dei dati personali |
Questo volume si propone di esplorare le specificità della disciplina in tema di privacy e protezione dei dati personali, offrendo un approccio olistico che fa dell’interdisciplinarità e della comparazione le necessarie chiavi di lettura per comprendere i fenomeni in atto. Fornire al giurista gli strumenti fondamentali per conoscere tali materie non è solo importante per introdurlo ad un ambito così innovativo del diritto, ma diviene essenziale per consentire l’acquisizione di una corretta consapevolezza sui rischi che la società dell’informazione porta con sé. |
privacy, diritti utente, web, diritto |
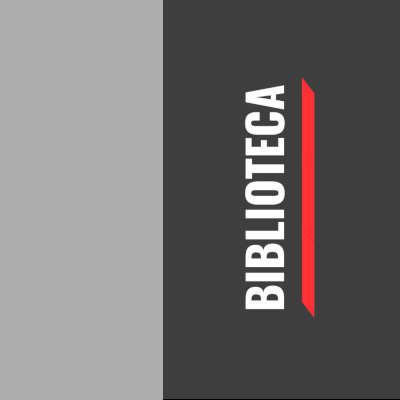
|
Digitale d’autore |
Il libro inizia con un’esplorazione introduttiva su come gli scrittori utilizzano i computer; fornisce una definizione di Archivio letterario nato-digitale, fornisce alcuni esempi dal panorama internazionale e realizza una mappatura degli archivi digitali in Italia con particolare attenzione all’Archivio di Franco Fortini tenutosi presso l’Università di Siena. Il volume offre una sintesi del primo progetto italiano dedicato agli archivi letterari italiani-digitali, PAD - Pavia Digital Archives, analizzando il processo di acquisizione e gestione dei materiali, ora conservati presso il Centro Manoscritti di Pavia. Infine, un’analisi critica delle prime tre opere di Francesco Pecoraro viene offerta attraverso un esame del suo archivio digitale a Pavia. |
archivi digitali, letteratura contemporanea |
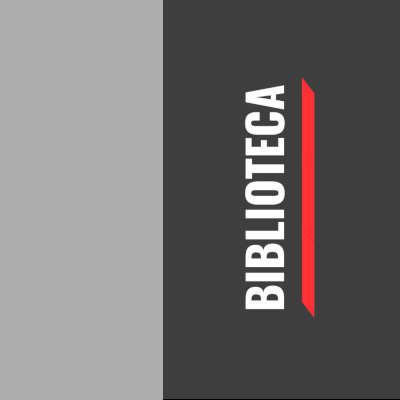
|
Design, Heritage e cultura digitale |
Con la trasformazione digitale, l’aumento esponenziale del numero di strumenti e tipologie di supporto con cui le espressioni umane possono essere create e trasmesse porta con sé nuovi paradigmi culturali che alimentano produzioni creative e viceversa, dando origine a nuove domande su come il patrimonio “funziona”, cosa “fa” e cosa “conservi”. Questo è il contesto generale in cui è ambientato il progetto di ricerca descritto in questo libro, e la convergenza che si è creata nel tempo tra tecnologie, patrimonio culturale e design, che oggi sembrano attuare una triangolazione in cui ogni vertice favorisce il rapporto tra gli altri due, aprendo nuove e interessanti prospettive di ricerca da esplorare. |
design, cultura digitale |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina
